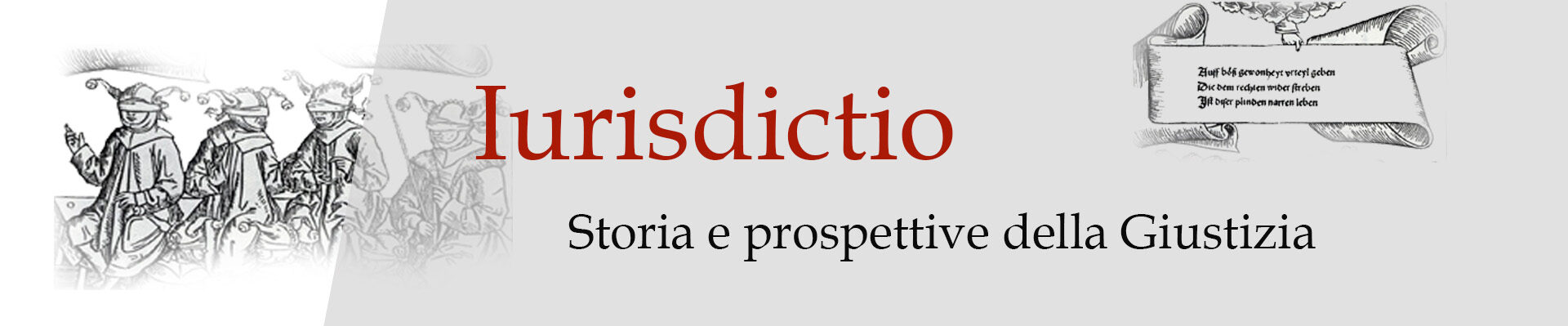Scarica l’articolo completo in pdf
THE REVOLT OF MESSINA IN 1847 AND THE OPEN CONFLICT BETWEEN THE JUDICAL AND EXECUTIVE POWERS
Abstract
Nell’avvicendarsi delle decretazioni emergenziali, la reità politica si inserisce inevitabilmente nelle nuove declinazioni codificate del crimen laesae maiestatis, e, di conseguenza, anche l’aggravamento della procedura a essa dedicata. È ora il rivoluzionario a essere stigmatizzato nelle liste di fuorbando, a divenire necessaria preda dello Stato. La non univocità dei destinatari del giudizio delle commissioni militari emerge palesemente allorquando ci si approccia alla specificità del «caso Sicilia», e precipuamente nel caso dei moti di Messina del 1° settembre 1847. Il decreto del 6 marzo 1834 esplicita la competenza delle commissioni militari per i crimini di attentato contro la sicurezza interna dello Stato. Ma è altresì la presenza di un elemento alieno al consesso militare, l’“uomo di legge”, il Procuratore generale del Re, che riveste il duplice ruolo di istruttore della procedura e di colui che fornisce un parere non vincolante, ma obbligatorio, teso comunque a condizionare l’operato delle commissioni. Attraverso l’esame di carteggi inediti tra il magistrato Giovanni Vignali e il Ministro di Grazia e Giustizia Nicola Parisio, si è inteso comprendere l’ambivalenza dell’“uomo di legge”, in equilibrio tra accusa e garanzia di una corretta raccolta delle prove a tutela degli imputati. Ineluttabilmente questa figura si pone in netto contrasto con la visione esclusivamente repressiva del potere politico e militare – e dei compiti della giustizia d’eccezione a esso connessi – rappresentata dall’Alter-ego del Re, il maresciallo Salvatore Landi.
Parole chiave: “Uomo di legge” – Messina 1847 – potere giudiziario – potere politico e militare